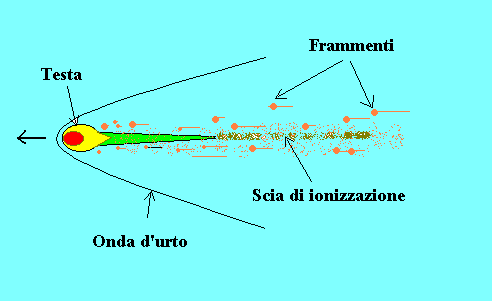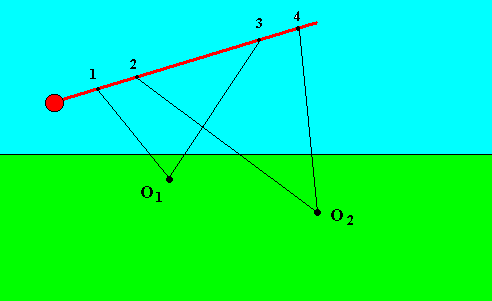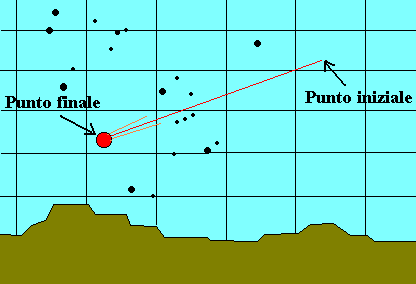| Introduzione Uno dei più
interessanti e spettacolari fenomeni astronomici cui è possibile assistere è senz'altro
il passaggio di un bolide (meteora molto luminosa). Purtroppo, essendo eventi
sporadici e imprevedibili, per la maggior parte dei bolidi è necessario ricorrere alle
osservazioni visuali di testimoni occasionali. Quando si è fortunati si può incappare in
qualche foto o filmato amatoriale. Di solito i testimoni sono impreparati ad affrontare
questo tipo d'evento e, a parte descrizioni pittoresche, i dati effettivamente utili sono
pochi. Questo è un peccato perché con un piccolo sforzo ciascuno di noi si può
preparare a gestire l'avvistamento di un bolide. Con un minimo di conoscenze è
possibile ricavare molte informazioni utili, anche da osservazioni ad occhio nudo.
I meteoroidi
In orbita attorno al Sole, oltre ai nove pianeti principali, si trovano
centinaia di migliaia d'asteroidi e milioni di comete. Gli asteroidi si
concentrano prevalentemente fra le orbite di Marte e Giove (fra 2.1 e 3.6 UA dal Sole), in
quella che è chiamata la fascia principale, mentre la maggior parte delle comete
popola le regioni esterne del Sistema Solare, dando origine alla nube di Oort (fra
40 000 e 100 000 UA). Gli asteroidi sono corpi rocciosi con diametri che vanno dai 950 km
di Cerere (il primo ad essere scoperto nel 1801), fino a 1 km per quelli più piccoli. Le
comete sono corpi prevalentemente ghiacciati che inglobano particelle solide. Le
dimensioni tipiche del nucleo di una cometa sono dell'ordine di 1-10 km.
Fra gli asteroidi le collisioni non sono nulle. Lo scontro fra due
asteroidi porta alla creazione di molti frammenti con dimensioni che vanno dal centesimo
di millimetro ad alcune decine di metri. Questi oggetti, intermedi fra asteroidi e polvere
interplanetaria, sono chiamati meteoroidi. I limiti fissati dall'IAU (International
Astronomical Union) nel 1961 considerano come meteoroidi i corpi con una massa compresa
fra 10-9 e 107 kg. Assumendo una densità di 3.5 g/cm3 il raggio di un meteoroide va da 40 micrometri a 10 m. Anche le comete sono una
"sorgente" di meteoroidi, ma di densità minore. Quelle comete che riescono a
raggiungere il Sistema Solare interno sono soggette ad un processo di sublimazione dei
ghiacci della superficie, che immette nello spazio interplanetario le particelle solide da
cui sono, in parte, formate. Si originano così delle vere e proprie "correnti di
meteoroidi" che seguono l'orbita della cometa-madre. Sono i meteoroidi di origine
cometaria a dare origine agli sciami meteorici visibili durante l'anno (fra i più
importanti: Quadrantidi, Perseidi, Leonidi, Geminidi). Qui siamo interessati ai meteoroidi
di origine asteroidale, che sono quelli di cui si conosce ancora poco.
Fisica dei bolidi
A causa delle risonanze orbitali con Giove e Saturno e dell'effetto
Yarkovsky, i meteoroidi originatisi nella fascia principale possono essere immessi in
orbite che intersecano quelle dei pianeti terrestri: Mercurio, Venere, Terra e Marte. Ci
sono quindi migliaia di piccoli corpi, delle dimensioni di qualche metro, potenzialmente
in grado di cadere sulla superficie terrestre.
La velocità geocentrica di un meteoroide appartenente al Sistema Solare è compresa fra
11.2 km/s (dovuta alla sola gravità terrestre), e 72.8 km/s (42.5 km/s per la velocità
di fuga al perielio terrestre più 30.3 km/s per la velocità orbitale della Terra al
perielio). Quando un meteoroide penetra nell'atmosfera terrestre con velocità dell'ordine
delle decine di km/s, la collisione con le molecole atmosferiche ne riscalda la
superficie. Giunto ad una quota di 80-90 km la temperatura del meteoroide raggiunge i 2500
K ed inizia la sublimazione degli atomi del corpo celeste. Questo processo di perdita di
massa è noto come ablazione. A causa degli urti reciproci gli atomi del meteoroide
si ionizzano e ionizzano anche le molecole atmosferiche. Durante la ricombinazione
ioni-elettroni è emessa della radiazione elettromagnetica, e un osservatore al suolo
vedrà una scia luminosa: la meteora.
Una meteora si compone di due parti: la testa e la scia. La testa della
meteora contiene il meteoroide che si sta consumando più i gas ionizzati, mentre la scia
è la regione di ricombinazione dei soli gas ionizzati. Il 90% della radiazione emessa da
una meteora proviene dagli atomi del meteoroide. Se il meteoroide è di discrete
dimensioni (> 20 cm di diametro), la testa della meteora può essere molto luminosa.
Quando la magnitudine apparente zenitale è inferiore a -8 la meteora è detta bolide
(un tempo il termine bolide era usato per indicare le meteore di cui era udibile il
rumore). La definizione di bolide non è ancora stata fissata dall'UAI, quindi per alcuni
la magnitudine limite è la -4 o la -6. Un bolide con magnitudine inferiore alla -17 è
detto superbolide. Per meteoroidi di decine di metri di diametro il bolide
può essere più luminoso del Sole visto dalla Terra. Un esempio di un evento del
genere è il meteoroide esploso sopra la regione del fiume Tunguska il 30 giugno 1908.
I testimoni superstiti parlarono di una "palla di fuoco" molto più
luminosa del Sole.
Spesso il meteoroide, a causa della differenza di pressione atmosferica fra parte
avanzante e recedente, si frammenta in più parti, ognuna delle quali diventa a sua
volta un bolide. Un fatto del genere si è verificato per il bolide visto da Peekskill
(stato di New York) la sera del 9 ottobre 1992. Il corpo principale si spezzò in 70
frammenti di cui uno solo (del peso di 12 kg) è stato ritrovato (colpì un'automobile
parcheggiata sfondando il cofano posteriore).
Se il meteoroide è sufficientemente grande può sopravvivere all'ablazione. Quando la
velocità in atmosfera scende al di sotto dei 3 km/s la perdita di massa e l'emissione di
radiazione cessa e il meteoroide entra nella fase di volo buio (o dark flight).
Da questo momento inizia un processo di raffreddamento della superficie e la
traiettoria del corpo si fa sempre più verticale.
La velocità di impatto del meteoroide sulla superficie terrestre va da 10 a 100 m/s per
corpi di massa compresa fra 10 g e 10 kg (velocità geocentrica di 15 km/s). Quando il
meteoroide giunge al suolo si parla di meteorite. La probabilità di
giungere al suolo, oltre che dalle dimensioni, dipende dal materiale di cui è fatto il
meteoroide. Un meteoroide di ferro-nichel giungerà più facilmente al suolo
di uno di pura roccia. Nell'impatto il meteoroide si conficca nel terreno creando una buca
che può essere anche più larga delle dimensioni del corpo che la provoca.
Per grandi meteoroidi o piccoli asteroidi la velocità può mantenersi elevata fino al
suolo, l'ablazione non cessa, non esiste la fase di volo buio e nella caduta si forma un
cratere da impatto.
È chiaro che l'avvistamento di un bolide molto luminoso, implica
l'entrata in atmosfera di un meteoroide di dimensioni tali da poter sperare che sopravviva
all'ablazione e giunga fino al suolo.
I satelliti militari di sorveglianza sono una buona sorgente di dati per quanto riguarda i
superbolidi, infatti i loro sensori IR sono in grado di rilevare i flare emessi.
L'unico problema è che è difficile ottenere i dati. In ogni caso, da quel poco che
è disponibile, si può stimare che, ogni anno, si disintegrano in atmosfera da 30 a 50
superbolidi (la maggior parte sopra gli oceani), da 2 a 4 al mese.
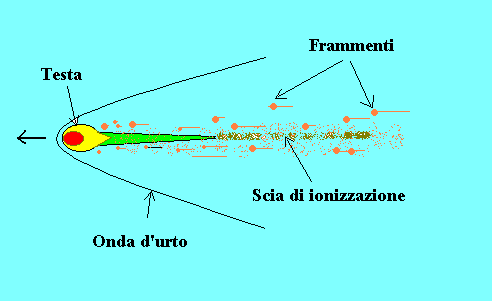 |
| Fig.1 - Rappresentazione schematica di un bolide. Sono
state indicate la testa del bolide, la scia di ionizzazione, l'onda d'urto causata dal
moto ipersonico nell'atmosfera e alcuni frammenti staccatisi dal corpo principale. La
freccia indica la direzione del moto. |
Il problema che si presenta è come trovare la possibile
meteorite una volta che si è osservato il bolide e come calcolarne l'orbita originaria
attorno al Sole. Considerato che le meteoriti provengono dal passato del Sistema Solare e
che sono ricche di informazioni di tipo chimico-fisico, vale senz'altro la pena cercarle.
Ogni bolide di cui non si riesce a stabilire nulla è una potenziale miniera di
informazioni persa. Per fare sì che la ricerca abbia una minima probabilità di successo
bisogna imparare ad osservare i bolidi.
Le conoscenze di base per l'osservatore
Il metodo più antico utilizzato si basa su osservazioni ad occhio nudo,
tuttora molto in voga in campo amatoriale per le osservazioni delle comuni meteore.
Le conoscenze di base necessarie per l'osservazione visuale dei bolidi sono relativamente
poche. Tenere presente che l'accuratezza delle osservazioni è direttamente proporzionale
all'esperienza "sul campo". Prima di tutto è necessario imparare a riconoscere
le stelle più luminose del cielo (Sirio, Vega, Altair, Antares, Deneb ecc.), i pianeti e
le costellazioni più importanti (Orsa Maggiore, Orione, Toro, Gemelli, Cigno, Scorpione
ecc.). Per raggiungere lo scopo è sufficiente munirsi di un piccolo atlante
stellare che riporti tutte le stelle visibili ad occhio nudo. Atlanti utili
per questo fine sono inseriti come appendici in quasi tutti i libri di introduzione
all'astronomia reperibili nelle comuni librerie. Dopo aver imparato a riconoscere
per sommi capi la volta stellata si possono iniziare le osservazioni. Non ci
sono indicazioni particolari sul periodo di osservazione o sulla zona di cielo da tenere
sotto controllo. I meteoroidi della fascia degli asteroidi, responsabili dei
grossi bolidi, possono cadere sulla Terra in ogni momento. Questo punto
differenzia notevolmente l'attività dell'osservatore di bolidi da quello dei comuni
sciami di meteore (di origine cometaria), che ha delle date ben precise in cui osservare.
Le osservazioni dovranno essere condotte da un luogo relativamente buio, da cui sia
possibile distinguere almeno le stelle più luminose (l'utilizzo di una sedia a sdraio è
consigliata per evitare crampi che possono distogliere l'attenzione dell'osservatore).
Naturalmente si dovrà avere a portata di mano l'atlante celeste, una piccola
torcia a luce rossa (per non abbagliare gli occhi), una penna e un blocco per gli appunti.
Non sono necessari strumenti ottici come binocoli o telescopi.
Dato il ridotto campo visivo di strumenti di questo tipo, si corre il rischio di non
osservare i pochi bolidi che sarebbero visibili: tutte le osservazioni vanno condotte ad
occhio nudo. Al limite un piccolo binocolo può essere utile per monitorare meglio
il fenomeno di persistenza della scia, ma non è indispensabile.
Può essere utile imparare a stimare le distanze angolari fra due punti della sfera
celeste. Questa stima può essere fatta molto velocemente, anche se in modo
approssimativo, utilizzando le mani. A braccio completamente disteso il pollice
sottende un angolo di circa 2°, il pugno chiuso 10° e la mano aperta (con le dita
separate) circa 20°. Questi valori possono cambiare leggermente da una persona
all'altra e vanno calibrati individualmente misurando angoli noti. Contando quanti
"pollici", "pugni" o "mani" si possono inserire fra due
punti dati della sfera celeste e moltiplicando per i valori precedenti, si trova la
distanza angolare. Una tecnica di questo tipo può essere utile per stimare l'angolo
sotteso dalla traiettoria percorsa dal bolide, oppure per stabilire, in prima
approssimazione, le coordinate azimutali dei punti di inizio e fine traiettoria (che però
andranno ricavate in modo più accurato dalla riduzione delle osservazioni).
Si può dare il proprio contributo all'osservazione dei bolidi anche senza intraprendere
campagne di osservazioni sistematiche. Basta avere una discreta conoscenza del cielo
notturno per fare in modo che la propria testimonianza si trasformi da puro racconto a
strumento di indagine.
I bolidi notturni
Abbiamo affermato che un grosso meteoroide può precipitare sulla Terra
in qualsiasi momento, quindi un bolide può comparire sia di giorno sia di notte a
qualsiasi ora e mese dell'anno. Insomma tutto il tempo che si trascorre all'aperto
è utile per l'osservazione dei bolidi. Naturalmente i bolidi notturni saranno più
facilmente visibili di quelli diurni. Questi ultimi potranno essere agevolmente osservati
solo se molto luminosi.
a) Osservazioni visuali
In generale per ricavare la traiettoria in atmosfera del bolide e il punto di impatto
al suolo del meteoroide, sono necessari i dati di almeno due osservatori posti a qualche
decina di km l'uno dall'altro. In pratica, nel caso di osservazioni visuali, più
osservatori ci sono e meglio è perché si possono mediare gli errori di osservazione.
Naturalmente i dati forniti devono essere di discreta qualità: indicazioni del tipo
"... l'ho visto andare da nord verso sud-est..." non sono molto
utili per la ricerca del meteorite o il calcolo della traiettoria e dell'orbita.
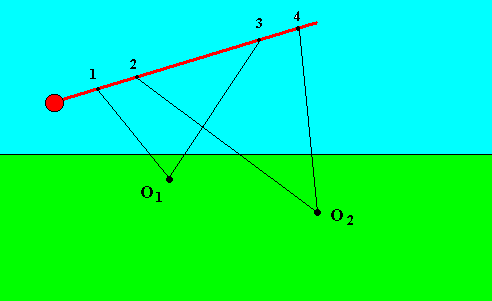 |
| Fig. 2 - Schema di triangolazione. Per individuare nello
spazio la traiettoria di un bolide sono necessari almeno due osservatori posti a qualche
decina di km di distanza l'uno dall'altro. In generale i punti indicati sulla traiettoria
del bolide da O1 e O2 sono diversi e questo complica i calcoli. |
Con il solo aiuto dei propri occhi si potrà osservare la
traiettoria che la testa del bolide segue fra le stelle visibili in quel momento. Non è
necessario ricordarsi tutta la traiettoria, basta registrare solo il punto in cui è
comparsa la testa del bolide (punto iniziale) e quello in cui è scomparsa (punto
finale).
L'osservazione della scia luminosa non è importante, bisogna concentrarsi sulla testa.
Dopo avere accuratamente osservato la traiettoria seguita dal bolide, ed
avere impresso nella memoria la posizione dei punti iniziali e finali, bisogna riportare
tutto su una carta celeste. Non si deve avere fretta: quando si osserva un
bolide bisogna concentrarsi sulla traiettoria, trascurando altri dettagli che potrebbero
distrarre. Dal disegno sulla mappa sarà possibile risalire alle coordinate
equatoriali dei punti di inizio e fine traiettoria.
Oltre a questo è indispensabile segnare ora e minuto dell'osservazione (specificando se
è estiva, TMEC o TU), e la durata del fenomeno. Vale a dire l'intervallo di tempo
impiegato dal bolide per spostarsi dal punto iniziale a quello finale. La stima del
tempo può essere fatta cominciando a contare mentalmente i secondi dal punto iniziale
della traiettoria. In alternativa si può rivedere mentalmente la sequenza degli
eventi e contare i secondi. L'importante è segnarsi subito l'intervallo di tempo,
per evitare che sia dimenticato. Il valore della durata permette di stimare la velocità
media del bolide.
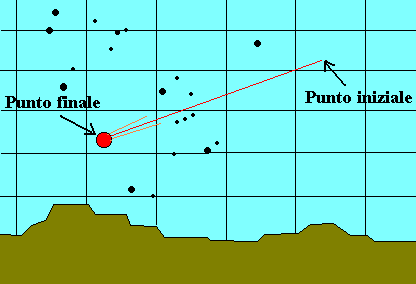
|
| Fig. 3 - I dati essenziali per l'osservazione di un bolide sono le
coordinate equatoriali dei punti iniziali e finali della traiettoria e la durata
dell'apparizione. |
Può succedere che un bolide sia osservato solo quando è
già comparso, perdendo così il punto iniziale. Ebbene questo non è un problema per
il calcolo della traiettoria. Basta registrare la posizione del punto della
volta celeste in cui si vede il bolide per la prima volta. La stessa considerazione
vale per il punto finale. Se, durante il tragitto dal punto iniziale a quello finale, il
bolide occulta stelle brillanti e facilmente riconoscibili è opportuno registrarlo.
Infatti, in questo modo, si danno i punti intermedi della traiettoria osservata; questi
dati aggiuntivi sono molto utili per la ricostruzione della traiettoria in atmosfera.
La magnitudine della testa del bolide può essere stimata confrontando la sua luminosità
con quella di altri corpi celesti noti. Ricordiamo che per Venere alla massima
luminosità, la magnitudine vale circa -4.4, per la Luna al primo quarto -10, per la Luna
piena -12.5, mentre per il Sole è di -26.8. Purtroppo non ci sono altri astri di
magnitudine intermedia con cui poter fare il confronto. È per questo motivo che le
stime di magnitudine dei bolidi sono sempre piuttosto incerte, ma è comunque meglio di
niente.
Quelli illustrati sopra sono i parametri fondamentali che vanno stimati per l'osservazione
utile dei bolidi.
Un altro fenomeno fisico che andrebbe monitorato è l'eventuale suono percepito. Se
il suono si ode contemporaneamente all'apparizione del bolide, allora si tratta di un
suono elettrofonico (di origine elettromagnetica), non dovuto alla propagazione di onde
sonore. Di solito questo tipo di suono assomiglia ad un sibilo. Se invece si
ode un suono cupo, ma dopo la sparizione del bolide, allora questo è dovuto alla
propagazione dell'onda d'urto in atmosfera ed è veicolato da normali onde di
compressione. Nell'osservazione di un bolide la segnalazione del tipo di suono è
interessante ma non fondamentale.
Altri dettagli come il colore, la persistenza della scia e la forma della testa sono
inessenziali e possono essere trascurati: troppi dettagli da ricordare possono
creare confusione, meglio limitarsi ai quattro dati essenziali (posizione del punto
iniziale, finale, durata e magnitudine della testa).
Naturalmente, per completare il rapporto, va indicata la località geografica da cui si è
osservato il bolide: latitudine, longitudine e quota sul livello del mare.
Riassunto sull'osservazione visuale dei bolidi
Dati
fondamentali |
Note |
| Sito di osservazione |
Latitudine, Longitudine, quota s.l.m. |
| Coordinate equatoriali del punto iniziale |
Ascensione retta e declinazione,
specificare l'equinozio |
| Coordinate equatoriali del punto finale |
Ascensione retta e declinazione,
specificare l'equinozio |
| Durata |
Misurata in secondi |
| Magnitudine della testa |
Usare come riferimento Luna e Sole |
| Suoni uditi |
Specificare se prima o dopo
l'avvistamento |
Dati
complementari |
Note |
| Colore (colori) |
Specificare la sequenza di colori assunta
dalla "testa" |
| Forma e diametro della testa |
Confrontare con il diametro apparente
della Luna |
| Persistenza della scia |
Indicare il tempo di persistenza in
secondi |
b) Osservazioni fotografiche
Nello studio delle meteore la fotografia è stata utilizzata sin dal novembre 1885,
quando L.Weinek scattò a Praga la prima fotografia di una meteora.
Le osservazioni fotografiche dei bolidi sono molto utili, specie se condotte in parallelo
con quelle visuali. Per iniziare può essere sufficiente una comune reflex (possibilmente
manuale), fissa su treppiede, con una pellicola di media sensibilità e dotata di un
obiettivo grandangolare come un 28 millimetri di focale o, al massimo, del normale
obiettivo da 50 mm. La reflex dovrà essere puntata verso la stessa regione di cielo che
si osserva visualmente e il tempo di posa può andare da 5 a 30 minuti, in funzione
dell'inquinamento luminoso presente. Nel caso un bolide attraversasse la zona sotto
osservazione va subito interrotta la posa.
A meno che il bolide non sia comparso subito dopo l'inizio della posa, sulla foto le
immagini delle stelle appariranno come archi di cerchio. Un'immagine di questo tipo
esteticamente non è il massimo ma ha un enorme valore perché consente di determinare con
precisione le coordinate di inizio e fine traiettoria, senza le incertezze associate
inevitabilmente all'osservazione visuale.
Un miglioramento viene dall'utilizzo di un telescopio dotato di montatura equatoriale sui
cui montare in parallelo la reflex. In questo caso si può controbilanciare la
rotazione terrestre e le immagini delle stelle risulteranno puntiformi, facilitando il
calcolo delle coordinate della traiettoria.
c) Osservazioni con la videocamera
Dalla semplice fotografia della scia di un bolide si risale alle coordinate dei punti
della traiettoria ma non alla durata temporale dell'evento che va ancora stimato
visualmente. Per superare questo scoglio ci sono due strade: dotare la macchina
fotografica di un settore rotante (complicato), oppure usare una videocamera amatoriale
molto sensibile. Una volta montata su treppiede e puntata in una direzione fissa, la
videocamera dovrà essere in grado di riprendere le stelle di terza-quarta grandezza e di
riportare data, ora, minuti e secondi su ogni immagine registrata. In questo modo, oltre
alle immagini del bolide e alle informazioni sulla traiettoria, si hanno anche i dati
temporali. L'unica limitazione può essere l'ampiezza del campo di ripresa della
videocamera, dell'ordine dei 15°, da confrontare con i 74° di campo del 28 mm e i 46°
del 50 mm di una reflex.
Storicamente il bolide con il maggior numero di riprese video è senz'altro quello
associato alla caduta della meteorite di Peekskill: sono stati ben 15 i videotape ottenuti
da varie località degli Stati Uniti orientali
Se la videocamera non è sufficientemente sensibile da registrare le stelle più luminose
non è detto che sia inutilizzabile per la ricerca sui bolidi. Infatti, perché le riprese
continuino ad essere utili, basta fare in modo che nel campo inquadrato ci siano anche
elementi, ben visibili, del paesaggio terrestre (come ad esempio dei lampioni posti ad una
certa distanza dall'osservatore). In questo modo è sacrificata una parte del campo di
ripresa, ma se il bolide passa nella zona di cielo osservata si può risalire facilmente
alle coordinate azimutali della traiettoria usando come riferimento quelle degli elementi
del paesaggio. Per ricavare queste ultime non è necessario usare un teodolite ma è
sufficiente una semplice fotografia notturna di una decina di secondi di posa, presa dallo
stesso punto e con la stessa inquadratura della videocamera: dalle coordinate azimutali
delle stelle registrate sulla pellicola si risale agevolmente a quelle degli elementi
terrestri che interessano e da qui si trovano quelle del bolide.
Fino a oggi sono solo quattro le meteoriti di cui si è potuto ricostruire l'orbita
attorno al Sole grazie alle fotografie o ai filmati della caduta: Pribram (Cecoslovacchia,
7 aprile 1959), Lost City (Oklahoma, 3 gennaio 1970), Innisfree (Alberta, Canada, 5
febbraio 1977), Peekskill (stato di New York, 9 ottobre 1992). Le orbite mostrano
un'origine di tipo asteroidale.
Bolidi diurni
Nel caso dei bolidi diurni, molto più rari di quelli notturni, non ci
sono le stelle che possono fare da punti di riferimento per la traiettoria e si dovrà
ricorrere necessariamente ad elementi del paesaggio, come case ed alberi. Un bolide ben
visibile in pieno giorno fu quello osservato dagli Stati Uniti e dal Canada occidentali il
10 agosto 1972. Il meteoroide responsabile di questo bolide raggiunse una quota
minima di 58 km e poi tornò nello spazio. Il diametro stimato di questo corpo celeste è
di circa 5 metri con una massa di 100 tonnellate.
Nel caso di sole osservazioni visuali di bolidi diurni la precisione delle osservazioni è
in generale più bassa rispetto ai bolidi notturni. In ogni caso è bene non
lasciare correre ma raccogliere tutte le informazioni possibili. Subito dopo
l'osservazione del bolide sarà necessario fare un veloce schizzo di quello che si è
osservato, avendo cura di segnare gli elementi principali del paesaggio e la traiettoria
del bolide rispetto a loro. Sul disegno andrebbero indicati azimut e altezza
sull'orizzonte (in gradi) dei punti iniziali e finali.
L'azimut di un qualsiasi punto della sfera celeste è l'angolo, contato da nord verso est,
fra il punto cardinale nord e la proiezione del punto sull'orizzonte. L'altezza è
l'angolo verticale fra il punto e l'orizzonte. Questi valori possono essere stimati
aiutandosi con le mani, come abbiamo detto prima. Non si trascuri di indicare anche il
punto da cui è stata compiuta l'osservazione, la località geografica, l'ora esatta e la
durata dell'apparizione.
Le osservazioni fotografiche dei bolidi diurni non sono praticamente fattibili, mentre le
osservazioni con la videocamera andranno portate avanti con le stesse modalità di quelle
notturne a bassa sensibilità.
L'ITAlian Superbolide Network (ITA.S.N.)
Non sono molti i programmi di ricerca dedicati alla osservazione dei
bolidi.
Negli USA è attiva la Florida Fireball Patrol, mentre è stata chiusa nel 1973 la Prairie
Bright-Meteor Network (PN), dello Smithsonian Astrophysical Observatory. Quest'ultima era
composta da 16 stazioni poste alla minima distanza di 250 km l'una dall'altra. Ogni
stazione era dotata di 4 fotocamere con un campo di vista di 90°.
Un'altra rete per lo studio dei bolidi era la Canadese MORP, attiva dal 1971 al 1985.
In Europa è in funzione l'European Fireball Network (EN), composta da 50 stazioni poste
alla distanza minima di 100 km l'una dall'altra. Ogni stazione è dotata di una fotocamera
con obiettivo fish-eye. L'EN è l'erede della Czechoslovak Network, fondata da Ceplecha e
Rajchl nel 1965.
In anni recenti diversi programmi di fotografia di meteore sono stati portati avanti da
astronomi non professionisti in Europa e in Giappone. I risultati sono regolarmente
pubblicati su WGN, il giornale dell'IMO (International Meteor Organization), su Radiant,
il giornale della Dutch Meteor Society e sul giapponese Memoirs of the Nippon Meteor
Society.
In Italia lo studio dei bolidi è lasciato al caso, visto che, oltre a non avere una rete
fotografica propria, il nostro paese non ospita nessuna stazione della EN. Stando così le
cose, agli inizi di febbraio 2000, è nata l'ITAlian Superbolide Network (ITASN), formata
da un certo numero di studiosi interessati al fenomeno dei (super)bolidi. Lo scopo
di ITASN è quello di creare una rete di osservatori visuali di bolidi sparsi sul
territorio nazionale e in grado di fornire le informazioni che abbiamo visto prima.
Naturalmente anche l'impiego di macchine fotografiche e videocamere sarà incoraggiata,
fino alla creazione di una piccola rete di stazioni osservative sparse sul territorio
nazionale. Lo scopo di questa iniziativa è anche quello di favorire la nascita, a livello
nazionale, di una reale collaborazione fra gli interessati al fenomeno dei bolidi. ITASN
ha dato il via ad un gruppo di discussione (mailing list) espressamente dedicata ai
bolidi. I messaggi scambiati fra i partecipanti della lista (attualmente una trentina),
possono essere consultati via Web all'indirizzo:
http://www.egroups.com/group/superbolidi
La partecipazione e collaborazione è aperta a tutti gli interessati.
Il 19 marzo 2000 a Bologna si è tenuto, a cura dell'Associazione Astrofili Bolognesi
(AAB), il primo workshop di ITASN. La partecipazione è stata numerosa e particolarmente
attiva, con interventi, proposte ed idee molto interessanti che andranno sviluppate e
portate avanti.
Il prossimo appuntamento importante sarà per l'organizzazione della prima scuola estiva
di osservatori di bolidi, che si terrà a Bologna nei primi giorni di settembre 2000.
La scuola estiva sarà fondamentale per la formazione degli osservatori perché
vedrà la partecipazione di astronomi di fama internazionale.
Bibliografia
 Carbognani A.,
Foschini L., "Meteore", CUEN, Napoli, 1999. Carbognani A.,
Foschini L., "Meteore", CUEN, Napoli, 1999.
 Ceplecha Z. et al,
"Superbolides", Meteoroids 98, Astron. Inst. Slovak Acad. Sci, Bratislava 1999,
p.37-54. Ceplecha Z. et al,
"Superbolides", Meteoroids 98, Astron. Inst. Slovak Acad. Sci, Bratislava 1999,
p.37-54.
 Ceplecha Z., Docobo J.A., "Video
Record of the Spain bolide of June 14, 1996: The atmospheric trajectory and orbit", Astronomy
& Astrophysics supplement series, Vol.138, p.1-9, 1999. Ceplecha Z., Docobo J.A., "Video
Record of the Spain bolide of June 14, 1996: The atmospheric trajectory and orbit", Astronomy
& Astrophysics supplement series, Vol.138, p.1-9, 1999.
 Ceplecha Z., Borovicka J., "Meteor
phenomena and bodies", Space Science Reviews, Vol.84, p.327-471, 1998. Ceplecha Z., Borovicka J., "Meteor
phenomena and bodies", Space Science Reviews, Vol.84, p.327-471, 1998.
 Ceplecha Z., "Impacts of
meteoroids larger than 1 m into the Earth's atmosphere", Astronomy and
Astrophysics, Vol.286, p.967-970, 1994. Ceplecha Z., "Impacts of
meteoroids larger than 1 m into the Earth's atmosphere", Astronomy and
Astrophysics, Vol.286, p.967-970, 1994.
|